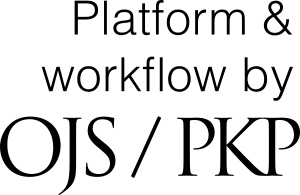Call for papers 2026
Numero monografico 2026. Fiabe e favole nei paesi slavi. Produzione – ricezione – circolazione. A cura di Emilio Mari e Monika Wozniak
Fiabe e favole nei paesi slavi. Produzione – ricezione – circolazione (PDF).
È passato ormai un secolo da quando Vladimir Propp, realizzando il progetto veselovskijano di una “morfologia della fiaba”, ha aperto la strada allo studio poetico-narratologico del testo folklorico, sottraendolo al dominio dell’idealizzazione romantica e della classificazione positivista. Eppure, nonostante la comparsa di alcuni studi dedicati alla presenza di motivi fiabeschi nell’opera di singoli autori e il crescente interesse verso la questione dell’“autorialità” (e della “falsificazione”) del testo orale, si avverte ancora oggi la mancanza di ricerche di ampio respiro che mirino a riconsiderare il genere della fiaba non solo in quanto langue, cioè espressione collettiva e universale del “popolo”, ma anche in quanto parole, cioè opera artistica storicamente determinata e frutto di scelte individuali di poetica e stilistica.
Se, infatti, gli studi proppiani (Morfologia della fiaba, 1928, traduzione italiana 1966, e Le radici storiche dei racconti di fate, 1946, traduzione italiana 1949) hanno incoraggiato l'interesse internazionale nei confronti dei racconti popolari russi, tuttavia, hanno anche contribuito alla tendenza a percepirli in primo luogo come una manifestazione della creatività contadina, una prospettiva che sembra ancora oggi prevalere in diversi ambiti. Inoltre, il filtro “tradizionalista” attraverso il quale le fiabe slave sono state spesso interpretate ha ritardato lo sviluppo di una solida tradizione di studi sulle trasformazioni contemporanee (rivisitazioni, transcreazioni, fiabe postmoderne, ecc. [si vedano, ad esempio, Bacchilega 1997, 2013; Joosen 2011]).
In Italia, in particolare, dopo un primo entusiasmo durante la stagione strutturalista, l’interesse scientifico per le fiabe e le favole slave si è quasi del tutto affievolito: i pochi studi disponibili si limitano a considerare la tradizione russa, o vengono in altri casi inseriti in una cornice più generale, come ad esempio quella della letteratura per l’infanzia. Scarse sono anche le traduzioni, fatta eccezione per le Antiche fiabe russe raccolte da Afanas’ev e poche altre.
Questo numero monografico di “Ricerche slavistiche” si propone di incoraggiare la riflessione sull’importanza letteraria, storica e culturale di questo genere espressivo nell’ambito dei paesi slavi, aprendo al tempo stesso a una sua analisi in una prospettiva comparata e transnazionale.
Invitiamo gli autori a proporre contributi inerenti (ma non limitati) ai seguenti temi:
- Ricezione e traduzioni delle fiabe slave in Italia
- Sviluppo storico dell’interesse per le fiabe e i racconti popolari nei paesi slavi
- Riflessione critico-metodologica sulle fiabe slave e sua ricezione italiana
- Folklorizzazione, ri-folklorizzazione, evoluzione e ibridazione di motivi fiabeschi
- Appropriazione culturale del racconto popolare attraverso le varianti letterarie
- Forme di autorialità mista (la figura del raccoglitore, del cantastorie, ecc.)
- Generi intermedi e di confine (fiabe scritte, fiabe letterarie, fiabe in versi, fiabe-lubok,
fiabe novellistiche e novelle a soggetto fiabesco, ecc.) - Ruolo delle fiabe e delle favole nello sviluppo della letteratura per l’infanzia
- Circolazione delle fiabe, delle loro traduzioni, versioni e degli adattamenti nei paesi slavi
- Falsificazione e manipolazione ideologica delle fiabe nei paesi slavi
- Ruolo delle fiabe nello sviluppo dell'identità nazionale e della memoria culturale
- Fiabe e racconti popolari oggi: riscritture, trasposizioni e rivisitazioni
Gli abstract, che non devono superare le 500 parole, possono essere redatti sia in italiano che in inglese e dovranno pervenire entro il 1° maggio 2025 ai seguenti indirizzi mail:
emilio.mari@uniroma1.it; monika.wozniak@uniroma1.it.
L’accettazione dei contributi verrà notificata entro il 1° giugno 2025. Gli articoli completi, che non dovranno superare i 50.000 caratteri (spazi inclusi), potranno essere redatti sia in italiano che in inglese e dovranno essere inviati entro il termine massimo del 31 dicembre 2025. Se non redatti da autori di madrelingua, i testi devono essere sottoposti a revisione linguistica da parte di un esperto prima della consegna.
La redazione invita anche contributi per altre sezioni della rivista: Studi e Ricerche, Ritratti, Discussioni e Recensioni. I testi pubblicati in queste sezioni possono essere redatti in italiano, in inglese o in qualsiasi lingua slava. Le proposte destinate a queste sezioni devono essere inviate a ricercheslavistiche.seai@uniroma1.it oppure a monika.wozniak@uniroma1.it entro il 1° dicembre 2025.