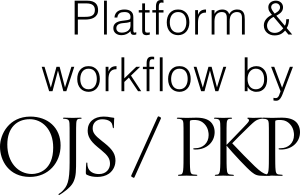Vol. 9 (2016): Memory, Structure, and Meaning: The Cognitive Dynamics of Textual Tradition
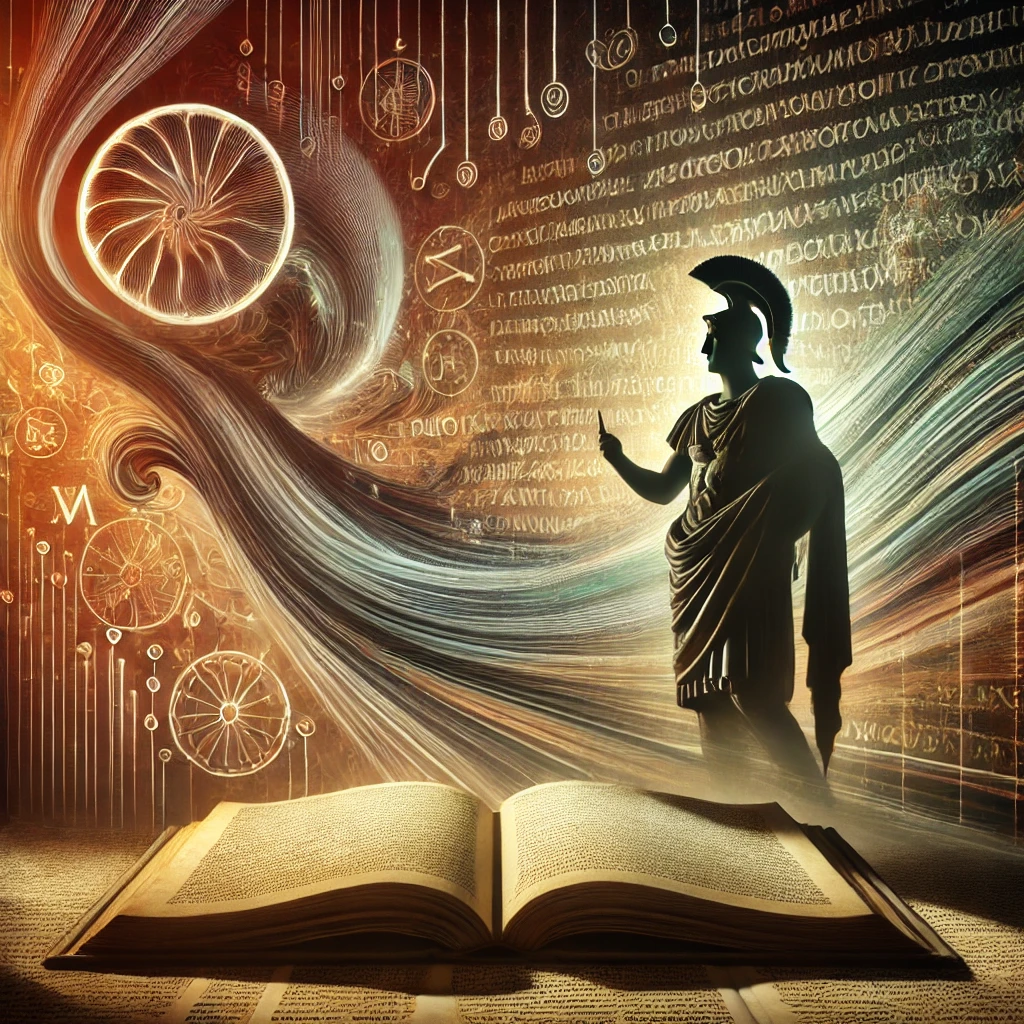
Tra le facoltà cognitive principali, la memoria, l'immaginazione e la creatività si pongono come elementi fondanti dell'esperienza umana. Fin dall’antica Roma, gli oratori affidavano alla "memoria" l’ossatura dei loro discorsi. Ma la loro 'arte' non si poggiava solo su rigorosi sistemi di apprendimento, bensì anche su una regolazione intenzionale delle emozioni. In tale contesto, l’immaginazione operava come strumento cognitivo per organizzare e rendere sensorialmente vividi i loci, potenziando così l’efficacia persuasiva del messaggio. Questa tensione tra oralità, persuasione e immaginazione si ritrova anche nella dimensione mistica del testo poetico. Le ricerche sugli stati alterati di coscienza mostrano come la ripetizione sonora – nelle pratiche estatiche così come nella composizione lirica – si configuri quale dispositivo ritmico capace di rimodellare la percezione. Non si tratta di pura estetica: la filologia cognitiva riconosce nel metro e nella scansione sonora leve che interagiscono attivamente con la mente del lettore. Anche lo studio stemmatico può essere ripensato alla luce della filologia cognitiva: l’impiego delle Auto Contractive Maps offre un modello dinamico per rappresentare la complessità e le ambiguità delle tradizioni manoscritte, integrando principi di auto-organizzazione e pattern cognitivi.