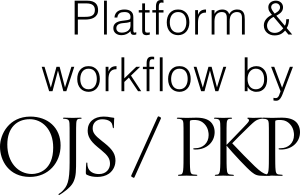Una lezione di antiretorica: Hemingway e gli scrittori italiani
DOI:
https://doi.org/10.13133/2532-1994_3.1_2019Abstract
La grande vitalità del modernismo americano trova in Hemingway un interprete particolarmente apprezzato nell'Italia del primo dopoguerra e un modello per una vasta platea di scrittori già affermati e di figure emergenti. Il suo rifiuto della retorica militarista in A Farewell to Armsdiventa una lezione estetica e politica per scrittori come Pavese e Vittorini e per chi, come Calvino, si avicina al romanzo immediatamente dopo la seconda guerra mondiale. Il successo di Hemingway è in larga parte dovuto all'uso di una narrazione scarna e reticente, scelta che si adatta perfettamente a rappresentare il vuoto esistenziale generato dall’assurdità della guerra.
Riferimenti bibliografici
Briasco, Luca. Retoriche del conflitto. Identità, amore e guerra in A Farewell to Arms di Ernest Hemingway. Roma: Lozzi & Rossi Editori, 2001.
Calvino, Italo. "La mia città è New York". In Rubeo Ugo. Mal d'America. Roma: Editori Riuniti, 1987.
Calvino, Italo. "Hemingway e noi", in Saggi. vol I. Milano: Meridiani Mondadori, 1995.
Fiedler, Leslie. Waiting For The End. New York: Stein and Day, 1970.
Gramsci, Antonio. Quaderni del carcere. vol. II, a cura di V. Gerratana. Torino: Einaudi, 1975.
Hemingway, Ernest. Addio alle armi (tr. it. F. Pivano). Milano: Mondadori, 1949.
Moravia, Alberto. "Due uova al piatto". In Mal d'America, Ibid.
Pavese, Cesare. "Ieri e oggi", L'Unità, 3 agosto 1947
Pasinetti, Pier Maria. "Il mal d'America". Ibid.
Soldati, Mario. "Uno scrittore di lingua inglese". Ibid.
##submission.downloads##
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza

Except where otherwise noted, the content of this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.